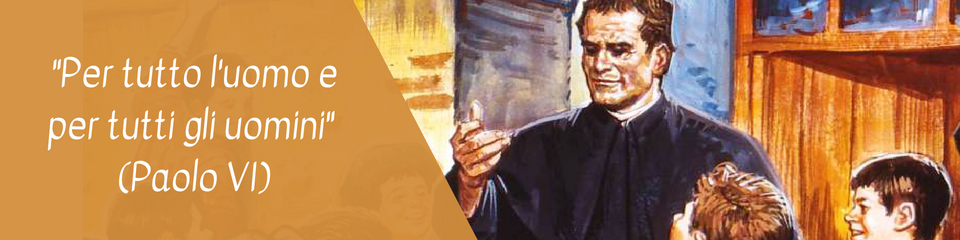L’autrice l’ha raccontata così, dal vivo. E noi ve la trasmettiamo. Non siamo in grado di dire se la protagonista avrebbe potuto far qualcosa di più per cercar di salvare l’amica dal suo naufragio umano, come forse avremmo desiderato. Ma ci sembra buona cosa raccontarvene la esperienza.
Come ogni sera i ricordi partivano dal proiettore della sua memoria per accavallarsi sul fragile lembo dei suoi azzurri occhi: e dall’oscurità qualcosa appariva sempre. Ora si vedeva seduta in riva al mare, con Valeria. Avevano trascorso un’ottima giornata insieme, e mentre il sole splendeva alto sui loro corpi magrolini aspettavano allegre che si asciugassero le ultime gocce d’acqua salata sui capelli scomposti e i bikini colorati, prima di tornare a casa, lavarsi e prepararsi per un’altra indimenticabile serata insieme. Sicuramente avrebbero incontrato Antonino e Marco. Valeria si sarebbe rabbuiata, sulle prime, per poi sfogare il suo malumore con colorite espressioni, mentre Maria alla vista di Marco si sarebbe limitata ad un lungo sospiro con gli occhi lucidi.
Erano così diverse, eppure talmente legate! Valeria, impulsiva e passionale, agiva sempre senza riflettere. Maria, riflessiva e calma, non si lasciava andare a eccessi di alcun tipo: composta, precisa, gentile. Manteneva la sua personalità e sembrava non essere un’adolescente soggetta al vento della crescita ma piuttosto un’adulta già formata. Questo aspetto affascinava Valeria e la istigava ad emulare l’amica: ma, per quanto ci provasse, Valeria non era come Maria.
Maria lo stava capendo solo adesso, da sola, nella sua stanza, mentre con la mente accarezzava un altro flebile ricordo: lei e Valeria si abbracciavano strette strette con una energia che da un momento all’altro sembrava esplodere in una scarica elettrica. Erano nella cameretta di Valeria, dove avevano parlato a lungo del futuro e dei loro sogni. Maria li aveva già “srotolati “davanti a sé come una larga strada sterrata da cui, in lontananza, si intravedeva luce, tanta luce. Sarebbe diventata una giornalista e avrebbe fatto di tutto per cambiare il mondo. Valeria, invece, si apprestava allora ad iniziare il viaggio e la sua strada era ripida, a tratti oscura, piena di fossi e brutte discese. Maria cercava allora di illuminarla, con la sua enfasi oratoria e il suo piccolo mondo interiore. Ed in queste fuggevoli ore trascorse insieme a sognare, Valeria e Maria erano un tutt’uno, un vortice di idee, di sentimenti, di speranze: erano amiche, ma amiche in una maniera assoluta. Un’amicizia pura e radiosa che le circondava senza che loro neanche se ne accorgessero.
Maria ricordava la prima volta che si erano viste, e da allora non aveva mai abbandonato Valeria. Quando quest’ultima si era innamorata per la prima volta, timorosa di aprire il suo cuore, Maria le era stata accanto ricordando come era buffa la solitudine in momenti simili: infatti quando era stata lei a innamorarsi non c’era stato nessuno a capirla. E allora cosa la spingeva a fare quel bene all’amica? Maria non lo sapeva: era fatta così! Dava senza pretendere niente in cambio. Ricordava quante parole e quanto coraggio aveva trasmesso all’altra e non le era mai pesato perché credeva in ciò che faceva e riusciva a gioire della felicità dell’altra. Quando vedeva Valeria tornare fra le braccia di Antonino quasi si commuoveva. Ne gioiva come vedendo realizzato il sogno che non era riuscita a realizzare con Marco: tra loro non c’era stata nessuna Maria; Maria, invece, c’era sempre stata per Valeria. C’era stata quando quella le riempiva la testa di chiacchiere inutili, c’era stata quando aveva bisogno di una spalla su cui piangere, c’era stata per prestarle soldi e vestiti, c’era stata per darle tutto l’affetto che le mancava in famiglia. C’era stata persino quando avevano scoperto Antonino a farsi di cocaina nel bagno di un locale e Valeria ne aveva pianto per una settimana. C’era stata sempre, eppure questo sembrava non esser bastato.
Ma ora tra loro si era posto il mare. Un’altra immagine le appariva dinanzi: un’immagine in cui non distingueva più le futili parole che quella le borbottava. Per Maria non era stata una buona giornata. Valeria era cambiata: Maria lo stava capendo pian piano, eppure non riusciva a tagliare del tutto il legame. Non capiva come quella specie di sanguisuga fallita avesse potuto prendere il posto della sua buona amica. Non poteva credere quella trasformazione di Valeria: era diventata insopportabile, parlava, parlava, parlava ma di una realtà distorta e astratta. “Io potrei fare tutto… Sono la migliore… Ma che ci vuole a fare quello che fai tu… Sono stufa di tutto… Nessuno si accorge del mio talento assoluto, che noia!...”. E intanto nulla faceva delle sue giornate e del suo futuro: non lavorava, non studiava, non ragionava, non sognava.
Sulle prime Maria non aveva voluto vedere. Era vissuta per anni con l’idea perfetta di Valeria e ora era impossibile accettare tacitamente quel mostro perverso. Scappare, scappare lontano… solo questo era il pensiero che affollava la sua mente dopo quella scoperta. E mentre un paio di lacrime clandestine scendevano veloci lungo le guance, Maria osservava la foto attaccata all’armadio e che ancora non era riuscita a staccare. Le piaceva quella foto: come era felice, Maria, in quella foto! Si perdeva in quel ricordo così nitido e straziante che quasi le veniva voglia di strappare furiosamente quel quadratino di carta in migliaia di pezzettini. Quelle due ragazze non esistevano più. Velocemente Maria vedeva passare una scena e poi un’altra e poi un’altra ancora: in ognuna di esse era triste. Aveva smesso di essere felice qualche mese prima, quando al posto di “Valeria l’amica” aveva trovato “Valeria la drogata” in discesa libera verso il baratro dell’animalità. Non capiva come quella avesse fatto a tuffarsi a capofitto in un tale gorgo. Eppure Valeria sapeva quanto sarebbe stato difficile uscirne! Avevano vissuto con Antonino quell’incubo: da perfetta egoista quale era diventata, Valeria aveva provato una volta e poi un’altra e un’altra ancora e adesso aveva trovato quell’ingannevole sogno che tanto anelava e ci si era perduta: quale sorpresa dovette provare Maria al sentirsi dare della bambina, della stupida, dell’immatura, della vecchia, della pavida! Dopo tutto quello che avevano passato insieme e il bene che le aveva unite come sorelle!
A questo pensiero, quasi immediatamente lo stupore fu sostituito da una rabbia furibonda a cui altrettanto rapidamente seguì un disgusto nero e una profonda sensazione di pena. Poi il silenzio. Il silenzio che non lasciava spazio neanche alla sofferenza. Valeria era lontana e irraggiungibile nel suo nuovo mondo di oche sgualdrine, di venditori di fumo, di nottate insonni nelle prigioni di menti impasticcate, di serpi insidiose di amici. Scheletri in attesa di un rantolo letale.
E quel mondo era lì ad un passo da Maria. Bastava dire sì. Bastava alzare il telefono ed assecondare l’irreparabile pazzia di Valeria. Ma Maria era destinata a ben altro: era cresciuta spingendo la carrozzina del suo migliore amico malato di distrofia muscolare e volato via troppo presto. Si commuoveva per strada quando constatava la solitudine e la sofferenza di un barbone o di una mendicante con figlio appeso al petto e già esausto d’essere al mondo. Sognava d’aprire un centro d’integrazione per famiglie straniere poco inserite nella comunità italiana: così Maria si era curata lungo l’intero anno di Yao, di Yuliana, di Ali, di Sued, di Majid, di Abbass. E nonostante le strade della vita li avessero portati altrove, Maria li portava nel cuore come pezzi della sua stessa esistenza, come motivi di crescita, di amore e di verità. Maria credeva in quell’oscura forza che muove il pensiero aspirando a migliorare l’animo umano e la realtà…Leopardi, Dumas, Dickens, Dante, Dostojevskji, Tolstoj, Pirandello… la prosa, la poesia, l’arte, l’amore, la verità…la vita! Questo era lei: il sogno e la speranza, il coraggio e la purezza, la giovinezza e la saggezza insieme. E non sarebbe cambiata.
Pensava a quelle indimenticabili presenze della sua vita: la zingara della stazione, il barbone del Tevere, la ragazza cinese dagli eterni inchini, la brasiliana scontrosa che si difendeva dagli uomini rozzi, il ragazzo del Bangladesh che a vent’anni era già sposato con due figli e frequentava la scuola solo per imparare la lingua italiana e trovare lavori migliori del venditore ambulante senza paga sicura, l’afghano scappato da Kabul col fratello minore dopo che le bombe e i talebani avevano reciso la vita dei genitori e della bellissima sorella Parvana recatasi alla fonte dell’acqua nel momento sbagliato.
Maria pensava a sua sorella Elisa, adottata in un tempo in cui Maria stessa non era ancora nata. Elisa bella e introversa, con gli occhioni scuri e la carnagione olivastra che tradivano le sue origini orientali, e quello sguardo da cui traluceva una storia incredibile, una di quelle storie fatte di abbandoni, dolori, ricordi confusi, sfide continue, paure. Ma era una storia di verità. La verità che Maria aveva scoperto in fondo alla sofferenza acuta che serra la vita nelle sale d’attesa degli ospedali, aspettando che Elisa scendesse dalla sala operatoria per un intervento alle gambe, alla vista, alle braccia, al seno. Eppure era ancora qui, Elisa, con gli occhi vivi e la voglia di vincere nonostante la malattia e la beffa della vita. Elisa era ancora pronta a lottare nonostante nei mesi seguenti dovesse rientrare in ospedale. E portava sempre il sorriso lucente di chi ancora può credere. Poi Maria pensava ai suoi genitori giusti, forti, stanchi, silenziosi, amorevoli, coraggiosi. Li accompagnava nella difficoltà impegnandosi affinchè ogni sua vittoria potesse divenire la luce di un sorriso anche per loro.
Così Maria aprì gli occhi. Si destò da quelle immagini caotiche e il silenzio solitario della sua stanza bastò alla netta scelta, una volta per tutte. Non avrebbe più cercato Valeria. E, in quella scelta, fu la vita.
(Anonimo, Premiopratoraccontiamoci)
°°°°°
MM
°°°°°
Silenzio. Tanto silenzio. Era ciò che negli ultimi tempi le teneva più compagnia. Come al solito, quella sera si era chiusa in camera, si era distesa sul letto e osservando il nulla incipriato dal bianco del soffitto cercava di dimenticare: dimenticare Valeria, gli amici, i suoi vent’anni passati così in fretta. Serrava quella porta della camera come per impedire al tempo di entrare e operarvi il cambiamento: eppure quanto era cambiata la realtà! A volte le sembrava così difficile poter continuare a sognare: non riusciva a bramare il futuro come le era accaduto in passato. Viveva in bilico, appesa alla costante sensazione di una decisione imminente da prendere e che tuttavia non riusciva a prendere. Come ogni sera i ricordi partivano dal proiettore della sua memoria per accavallarsi sul fragile lembo dei suoi azzurri occhi: e dall’oscurità qualcosa appariva sempre. Ora si vedeva seduta in riva al mare, con Valeria. Avevano trascorso un’ottima giornata insieme, e mentre il sole splendeva alto sui loro corpi magrolini aspettavano allegre che si asciugassero le ultime gocce d’acqua salata sui capelli scomposti e i bikini colorati, prima di tornare a casa, lavarsi e prepararsi per un’altra indimenticabile serata insieme. Sicuramente avrebbero incontrato Antonino e Marco. Valeria si sarebbe rabbuiata, sulle prime, per poi sfogare il suo malumore con colorite espressioni, mentre Maria alla vista di Marco si sarebbe limitata ad un lungo sospiro con gli occhi lucidi.
Erano così diverse, eppure talmente legate! Valeria, impulsiva e passionale, agiva sempre senza riflettere. Maria, riflessiva e calma, non si lasciava andare a eccessi di alcun tipo: composta, precisa, gentile. Manteneva la sua personalità e sembrava non essere un’adolescente soggetta al vento della crescita ma piuttosto un’adulta già formata. Questo aspetto affascinava Valeria e la istigava ad emulare l’amica: ma, per quanto ci provasse, Valeria non era come Maria.
Maria lo stava capendo solo adesso, da sola, nella sua stanza, mentre con la mente accarezzava un altro flebile ricordo: lei e Valeria si abbracciavano strette strette con una energia che da un momento all’altro sembrava esplodere in una scarica elettrica. Erano nella cameretta di Valeria, dove avevano parlato a lungo del futuro e dei loro sogni. Maria li aveva già “srotolati “davanti a sé come una larga strada sterrata da cui, in lontananza, si intravedeva luce, tanta luce. Sarebbe diventata una giornalista e avrebbe fatto di tutto per cambiare il mondo. Valeria, invece, si apprestava allora ad iniziare il viaggio e la sua strada era ripida, a tratti oscura, piena di fossi e brutte discese. Maria cercava allora di illuminarla, con la sua enfasi oratoria e il suo piccolo mondo interiore. Ed in queste fuggevoli ore trascorse insieme a sognare, Valeria e Maria erano un tutt’uno, un vortice di idee, di sentimenti, di speranze: erano amiche, ma amiche in una maniera assoluta. Un’amicizia pura e radiosa che le circondava senza che loro neanche se ne accorgessero.
Maria ricordava la prima volta che si erano viste, e da allora non aveva mai abbandonato Valeria. Quando quest’ultima si era innamorata per la prima volta, timorosa di aprire il suo cuore, Maria le era stata accanto ricordando come era buffa la solitudine in momenti simili: infatti quando era stata lei a innamorarsi non c’era stato nessuno a capirla. E allora cosa la spingeva a fare quel bene all’amica? Maria non lo sapeva: era fatta così! Dava senza pretendere niente in cambio. Ricordava quante parole e quanto coraggio aveva trasmesso all’altra e non le era mai pesato perché credeva in ciò che faceva e riusciva a gioire della felicità dell’altra. Quando vedeva Valeria tornare fra le braccia di Antonino quasi si commuoveva. Ne gioiva come vedendo realizzato il sogno che non era riuscita a realizzare con Marco: tra loro non c’era stata nessuna Maria; Maria, invece, c’era sempre stata per Valeria. C’era stata quando quella le riempiva la testa di chiacchiere inutili, c’era stata quando aveva bisogno di una spalla su cui piangere, c’era stata per prestarle soldi e vestiti, c’era stata per darle tutto l’affetto che le mancava in famiglia. C’era stata persino quando avevano scoperto Antonino a farsi di cocaina nel bagno di un locale e Valeria ne aveva pianto per una settimana. C’era stata sempre, eppure questo sembrava non esser bastato.
Ma ora tra loro si era posto il mare. Un’altra immagine le appariva dinanzi: un’immagine in cui non distingueva più le futili parole che quella le borbottava. Per Maria non era stata una buona giornata. Valeria era cambiata: Maria lo stava capendo pian piano, eppure non riusciva a tagliare del tutto il legame. Non capiva come quella specie di sanguisuga fallita avesse potuto prendere il posto della sua buona amica. Non poteva credere quella trasformazione di Valeria: era diventata insopportabile, parlava, parlava, parlava ma di una realtà distorta e astratta. “Io potrei fare tutto… Sono la migliore… Ma che ci vuole a fare quello che fai tu… Sono stufa di tutto… Nessuno si accorge del mio talento assoluto, che noia!...”. E intanto nulla faceva delle sue giornate e del suo futuro: non lavorava, non studiava, non ragionava, non sognava.
Sulle prime Maria non aveva voluto vedere. Era vissuta per anni con l’idea perfetta di Valeria e ora era impossibile accettare tacitamente quel mostro perverso. Scappare, scappare lontano… solo questo era il pensiero che affollava la sua mente dopo quella scoperta. E mentre un paio di lacrime clandestine scendevano veloci lungo le guance, Maria osservava la foto attaccata all’armadio e che ancora non era riuscita a staccare. Le piaceva quella foto: come era felice, Maria, in quella foto! Si perdeva in quel ricordo così nitido e straziante che quasi le veniva voglia di strappare furiosamente quel quadratino di carta in migliaia di pezzettini. Quelle due ragazze non esistevano più. Velocemente Maria vedeva passare una scena e poi un’altra e poi un’altra ancora: in ognuna di esse era triste. Aveva smesso di essere felice qualche mese prima, quando al posto di “Valeria l’amica” aveva trovato “Valeria la drogata” in discesa libera verso il baratro dell’animalità. Non capiva come quella avesse fatto a tuffarsi a capofitto in un tale gorgo. Eppure Valeria sapeva quanto sarebbe stato difficile uscirne! Avevano vissuto con Antonino quell’incubo: da perfetta egoista quale era diventata, Valeria aveva provato una volta e poi un’altra e un’altra ancora e adesso aveva trovato quell’ingannevole sogno che tanto anelava e ci si era perduta: quale sorpresa dovette provare Maria al sentirsi dare della bambina, della stupida, dell’immatura, della vecchia, della pavida! Dopo tutto quello che avevano passato insieme e il bene che le aveva unite come sorelle!
A questo pensiero, quasi immediatamente lo stupore fu sostituito da una rabbia furibonda a cui altrettanto rapidamente seguì un disgusto nero e una profonda sensazione di pena. Poi il silenzio. Il silenzio che non lasciava spazio neanche alla sofferenza. Valeria era lontana e irraggiungibile nel suo nuovo mondo di oche sgualdrine, di venditori di fumo, di nottate insonni nelle prigioni di menti impasticcate, di serpi insidiose di amici. Scheletri in attesa di un rantolo letale.
E quel mondo era lì ad un passo da Maria. Bastava dire sì. Bastava alzare il telefono ed assecondare l’irreparabile pazzia di Valeria. Ma Maria era destinata a ben altro: era cresciuta spingendo la carrozzina del suo migliore amico malato di distrofia muscolare e volato via troppo presto. Si commuoveva per strada quando constatava la solitudine e la sofferenza di un barbone o di una mendicante con figlio appeso al petto e già esausto d’essere al mondo. Sognava d’aprire un centro d’integrazione per famiglie straniere poco inserite nella comunità italiana: così Maria si era curata lungo l’intero anno di Yao, di Yuliana, di Ali, di Sued, di Majid, di Abbass. E nonostante le strade della vita li avessero portati altrove, Maria li portava nel cuore come pezzi della sua stessa esistenza, come motivi di crescita, di amore e di verità. Maria credeva in quell’oscura forza che muove il pensiero aspirando a migliorare l’animo umano e la realtà…Leopardi, Dumas, Dickens, Dante, Dostojevskji, Tolstoj, Pirandello… la prosa, la poesia, l’arte, l’amore, la verità…la vita! Questo era lei: il sogno e la speranza, il coraggio e la purezza, la giovinezza e la saggezza insieme. E non sarebbe cambiata.
Pensava a quelle indimenticabili presenze della sua vita: la zingara della stazione, il barbone del Tevere, la ragazza cinese dagli eterni inchini, la brasiliana scontrosa che si difendeva dagli uomini rozzi, il ragazzo del Bangladesh che a vent’anni era già sposato con due figli e frequentava la scuola solo per imparare la lingua italiana e trovare lavori migliori del venditore ambulante senza paga sicura, l’afghano scappato da Kabul col fratello minore dopo che le bombe e i talebani avevano reciso la vita dei genitori e della bellissima sorella Parvana recatasi alla fonte dell’acqua nel momento sbagliato.
Maria pensava a sua sorella Elisa, adottata in un tempo in cui Maria stessa non era ancora nata. Elisa bella e introversa, con gli occhioni scuri e la carnagione olivastra che tradivano le sue origini orientali, e quello sguardo da cui traluceva una storia incredibile, una di quelle storie fatte di abbandoni, dolori, ricordi confusi, sfide continue, paure. Ma era una storia di verità. La verità che Maria aveva scoperto in fondo alla sofferenza acuta che serra la vita nelle sale d’attesa degli ospedali, aspettando che Elisa scendesse dalla sala operatoria per un intervento alle gambe, alla vista, alle braccia, al seno. Eppure era ancora qui, Elisa, con gli occhi vivi e la voglia di vincere nonostante la malattia e la beffa della vita. Elisa era ancora pronta a lottare nonostante nei mesi seguenti dovesse rientrare in ospedale. E portava sempre il sorriso lucente di chi ancora può credere. Poi Maria pensava ai suoi genitori giusti, forti, stanchi, silenziosi, amorevoli, coraggiosi. Li accompagnava nella difficoltà impegnandosi affinchè ogni sua vittoria potesse divenire la luce di un sorriso anche per loro.
Così Maria aprì gli occhi. Si destò da quelle immagini caotiche e il silenzio solitario della sua stanza bastò alla netta scelta, una volta per tutte. Non avrebbe più cercato Valeria. E, in quella scelta, fu la vita.
(Anonimo, Premiopratoraccontiamoci)
°°°°°
MM