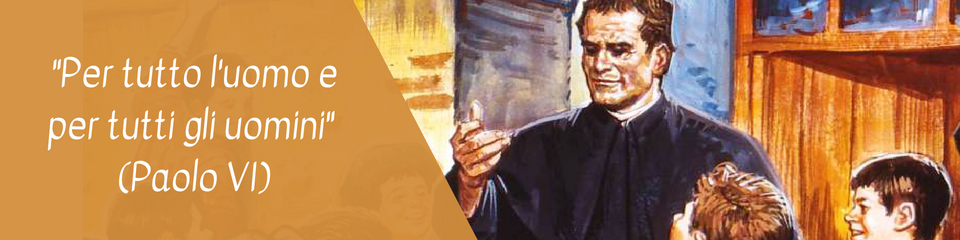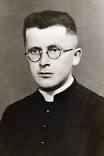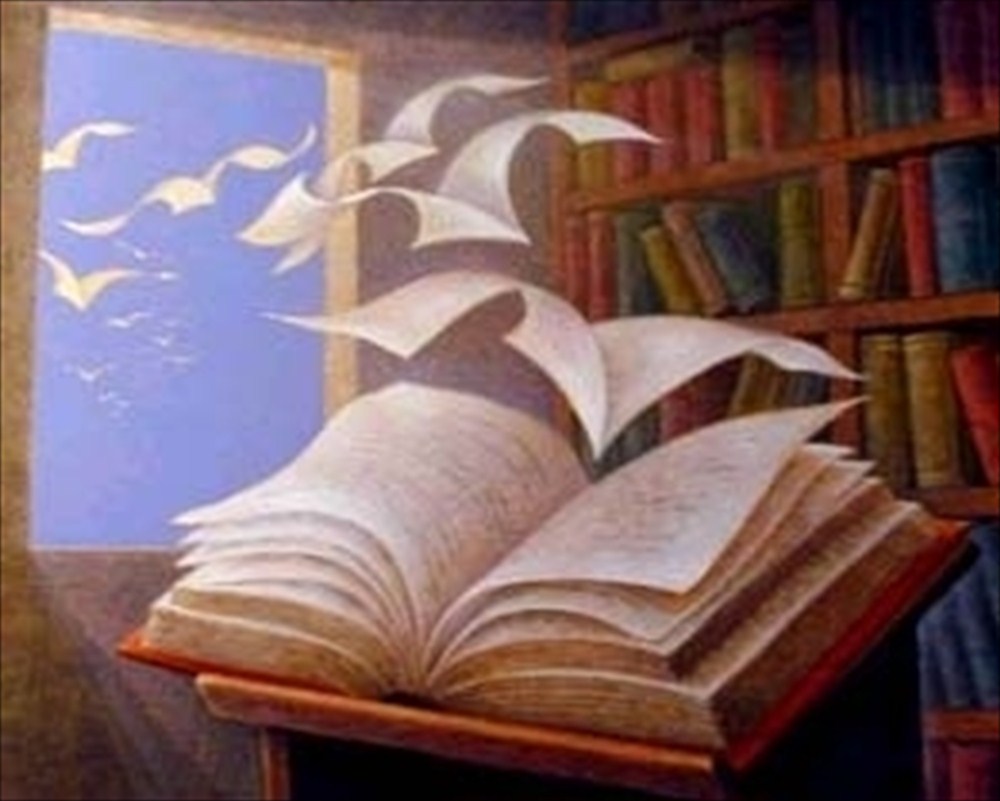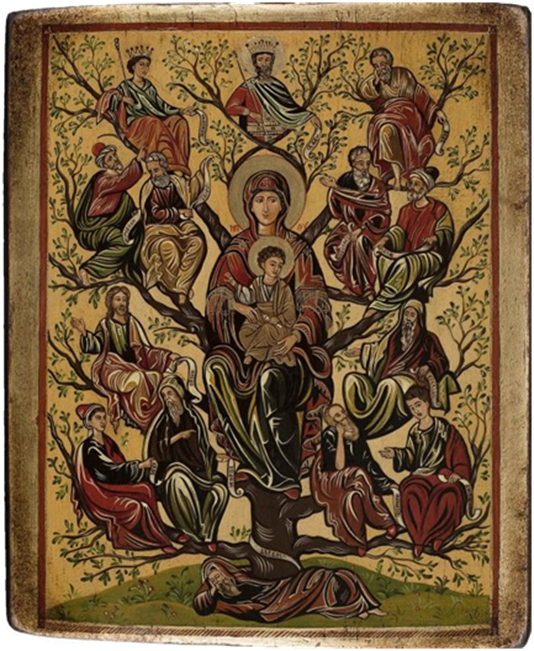Caro Giuseppe, tardo un po’ nel mantenere l’impegno di comunicarti un’“idea” avuta nel periodo estivo. Le motivazioni di questo mio attardarmi sono due: una è dovuta alla mia funzione di nonno e l’altra, la più importante, è dovuta alla titubanza di continuare ad impegnarmi in ricerche culturali e sociali, non possedendo la strumentazione culturale adeguata per diffondere e rendere fruibili ad altri dei pensieri che necessariamente vanno messi in comune per ottenere una ”grande idea”, la quale diventa tale proprio perché non resta racchiusa in un cervello ma viene condivisa fino a raggiungere una partecipazione sociale e quindi politica. La propria idea può appagare la propria indole ma, se non diventa “generativa”, resta sterile.Comunque, siccome sei “un cocciuto stimolatore di speranza”, non fosse altro per il rispetto che provo per la tua persona e per il tuo impegno ti invio questo scritto immaginando che sia per te di una qualche utilità.
°°°°°
Traguardare col filo a piomboUna delle materie scolastiche che insegnavano a noi ragazzini che frequentavamo la Scuola Professionale per l’industria e l’artigianato di Voghera, aveva un nome strano: si chiamava
“Occhio”, e si traduceva nell’apprendere non a guardare ma a traguardare, e cioè a frapporre tra il tuo occhio e l’oggetto in osservazione un punto di riferimento in modo da allinearlo al tuo campo visivo.
Nella fattispecie ti parlo del
filo a piombo, che è uno strumento semplice, usato nel tempo per verificare la verticalità di un oggetto. Nel caso concreto mi è stato utile nei primi anni di lavoro svolto nelle valli biellesi per posare i pali di sostegno dei conduttori elettrici.
In quei primi anni di lavoro (1966-1968) l’attività prevalente che svolgevo era quella di piantare pali e tirare fili, ed in alcuni casi, quando questi rasentavano il percorso stradale, appendere i lampioni. Erano gli anni della
nazionalizzazione di Enel e si dovevano cambiare e modernizzare tutte le linee elettriche che erano obsolete ed inadeguate allo sviluppo che il Paese stava vivendo.
Non esistevano allora mezzi adeguati che alleviassero la fatica fisica nello svolgere tale lavoro e, nelle vallate, il tutto si svolgeva
“a mano” e ad
“a occhio”. Potrà apparirti strano che ti parli di questo ma, credimi, piantare un palo che sia perfettamente in verticale rispetto a tutti gli angoli d’osservazione e prevedere
“a fiuto” quale piccola pendenza lasciare affinchè lo stesso ritorni alla perpendicolarità con il peso dei conduttori e dei lampioni di pubblica illuminazione, senza
utilizzare “il filo a piombo” è impossibile.
Oggi, con l’utilizzo di strumenti laser e di mezzi meccanici, è tutt’altro: ma, allora, quello si usava e, benché fosse di uso semplice, si trovava sempre
qualcuno che obiettava che, a suo modo di vedere, il palo pendeva da una parte o dall’altra: e lì, se si voleva mettere la parola fine alla discussione,
“il filo a piombo”, che non pende per propria natura, ti salvava.
Un tale modo di guardare o, meglio, di traguardare, mi è rimasto appiccicato sulla pelle e quindi anche la mia vita, e quella sociale, la guardo e la traguardo usando lo stesso metodo di riferimento e di verifica. Non più il
“filo a piombo” ma
alcuni valori che già in giovane età mi si sono incarnati e che, pur in modo intermittente, tutt’ora mantengo ben saldi.
Veniamo all’oggi: ma non subito. Ancora un ricordo, perchè ho visto che fai docenza ad un percorso formativo dal titolo
”Memoria e futuro”: ed allora… ancora un po’ di memoria.
Nell’aprile del
1997, in segreteria regionale Flaei (
il sindacato dei lavoratori elettrici della Cisl, ndr), si pensò di predisporre una copertina che richiamasse i temi contenuti nella relazione congressuale piemontese. Non sto a dilungarmi nella descrizione delle tematiche di tale relazione perchè le conosci bene quanto me:
Le
problematiche europee, l’allargamento degli Stati partecipanti, l’influenza che tale situazione poteva avere sul sindacato e sui lavoratori…
Le
dinamiche dei “capitali oscuri” che spostavano i risparmi familiari in investimenti azionari rendendoli economicamente appetibili ma privatizzandone la speculazione a vantaggio di pochi .
Il fenomeno dei
poveri e delle migrazioni che si affacciavano al mondo, e che in una città come Torino erano già presenti nel sottobosco lavorativo, ed avrebbero sorpassato in quantità esponenziale le problematiche legate alle migrazioni Fiat.
Nello specifico del nostro settore elettrico, la privatizzazione e lo
spezzatino di Enel, che ha prodotto l’esborso azionario delle famiglie italiane per un valore approssimativo di 30.000 miliardi di lire per riacquistare una parte di Ente che era già loro e che trasformerà definitivamente dal prossimo anno 2019 l’utente in cliente. Chi capisce
la differenza che passa tra “utenza” e “clientela” non ha bisogno di parole di commento.
Ci fu una discussione che durò per qualche tempo, sull’opportunità o meno di inserire, nella copertina del volumetto che conteneva la relazione congressuale, la scritta in rosso
“dagli un’anima” (al sindacato, s’intende: è una scritta che ricorderai). I temi trattati allora sono ancora di tutta attualità ed irrisolti, ma il dibattito era su quella scritta, che poi non venne stampata. Qual’era la
motivazione che mi spingeva ad inserirla?
Vent’anni fa la percezione che si respirava nel mondo del lavoro e tra lavoratori e imprenditori era mutata rispetto a quella del primo dopoguerra, dove ancora
la dignità ed il valore di una persona venivano identificati con la professione che la persona svolgeva, tant’è che non era raro trovare in Torino persone che parlando dell’
Avvocato (Agnelli) lo chiamavano “Giuanin-lamera”, colui che, grazie ai suoi predecessori, aveva fatto di Fiat una cultura e un simbolo di prestigio internazionale (e nel 1966 ne divenne presidente).
Eravamo già nel post-industria, con le tecnologie, la robotica, i supporti informatici, la cultura sociale, le conquiste sindacali, ecc… Non c’era più, nè si veniva percepiti più,come valore in quanto capaci di esercitare nella vita una professione: decideva ormai il successo di se stessi o dell’impresa.
Il mondo si era ristretto. Le grandi aziende si chiamavano ormai
holding, i supermercati avevano soppiantato la media distribuzione, molte erano le aziende che de-localizzavano alla ricerca di un più alto profitto. Tradotto e sintetizzato un po’ volgarmente,
“la persona ed il prodotto cessavano di essere tali per la loro qualità o quantità intrinseca”. Mentre in casa sindacale si discuteva di consumismo, alienazione,realizzazione di sé attraverso la professione, altri lavoravano alacremente per la
“finanziarizzazione” di ogni cosa, sia che fosse un oggetto sia che fosse una persona, un prodotto o un popolo, uno stato, un continente. Tutto correva veloce e la finanza allegra galoppava.
Ancora un passettino indietro. Da pochi anni era caduto il
Muro di Berlino e l’accorpamento dell’ovest con l’est della Germania avvenne con il concambio di valore della moneta di uno a uno. In pratica l’Ovest fece la lungimirante scelta politica di
“parità di valore” rendendo la Nazione omogenea a se stessa e spostando il baricentro geografico-politico del commercio europeo sul proprio territorio, e allargando l’Unione ai Paesi dell’Est. La
“parte vincitrice della Germania” seppe “traguardare”, non si limitò ad una raggiunta unità territoriale. Spostò l’orizzonte ad est e così, in Europa, divenne
“geograficamente centrale”, con tutto ciò che tale centralità ha comportato. Non la stessa lungimiranza, successivamente, fu applicata da parte nostra con l’introduzione dell’Euro (pensa solo per un attimo se, nel mentre si dibatteva dell’allargamento ad est, in quell’alta assise politica europea si fosse posto il problema dei migranti mediterranei che già allora “lavavano i vetri delle auto” nelle nostre città).
Con la caduta del muro, e sostanzialmente del Blocco Sovietico, cadde anche il marxismo: ed il capitalismo festeggiò se stesso. Molti furono gli onori che si auto-attribuì, alcuni anche meritati,
“la proprietà privata” apparentemente aveva vinto su un ideologia che la riteneva un’idiozia, e molti di noi hanno esultato tant’è che di lì a poco Papa Wojtyla ritenne utile la promulgazione dell’
enciclica Centesimus Annus che richiamava all’attenzione i cento anni trascorsi dalla Rerum Novarum ma anche rimodulava il pensiero della dottrina sociale, e questo nonostante nei precedenti anni avesse già promulgato la
Laborem exercens sul lavoro umano, e la
Sollicitudo rei socialis sui problemi dello sviluppo degli uomini e dei popoli.
Lavorando in Cisl avevo avuto l’opportunità di avere contatti diretti con alcuni esponenti di
Solidarnosc, e di seguirne per un certo periodo l’affermazione. Ben sapevo il ruolo che Papa Wojtyla e la Chiesa avevano giocato nella caduta del Muro e del Blocco: non tanto nell’affermazione del capitalismo ma bensì nel coagulo dei bisogni di un popolo in un movimento che per la dignità della propria vita, non solo lavorativa, per la prima volta nella storia conosciuta
“disarcionava un potere” senza incorrere in una rivoluzione più o meno violenta ma, con lotte anche rischiose e con estenuanti trattative, sbriciolava il muro ed il centenario conflitto ideologico tra capitale e lavoro. Un
“quasi miracolo”, di portata storica.
Non la faccio tanto lunga, questi aspetti li conosci quanto me e meglio di me. Quelle erano le pulsioni che provavo quando insistevo un po’ su quel
“dagli un’ anima”. Vedi, vivendo in Torino e seguendo un po’ le dinamiche politiche cittadine, avvertivo ciò che in seguito si sarebbe sviluppato sul territorio nazionale e cioè il fatto che si formasse una
“saldatura di compromesso” tra
il potere del capitale (Fiat) ed il Potere del Popolo (politica locale) fissando libertà di movimento e di riconoscimento. In termini concreti Fiat lasciava la gestione della comunità a condizione che la stessa lasciasse libertà di movimento e non interferisse più sulle scelte del capitale aziendale. Si ridussero i conflitti di fabbrica, si ridussero i conflitti sociali nel territorio e gli ex comunisti o socialisti governarono Torino, il Piemonte e parte dell’Italia accreditati in tutte le strutture sia pubbliche sia private, nelle Università come nelle Banche e Assicurazioni, nella Stampa ecc., fino allo scorso anno con l’avvento dei 5 stelle, i quali non mi pare abbiano capacità o volontà di modificare tale
“accordo non scritto” ma applicato.
Il potere economico, su scala mondiale, aveva dichiarato il
“cessate il fuoco” ideologico, lasciando la gestione della Polis ai partiti purchè non interferissero più di tanto sulla gestione privatistica del capitale. In gergo comune
“si riposizionava” e se, a mio avviso, il mondo del lavoro non alzava l’asticella del
“dagli un’anima ”, sarebbe rimasto risucchiato nell’
“Economia Politica” del Paese, lasciando mano libera ad un sistema economico che già si stava spostando verso un sistema non più industriale ma finanziario. Il lavoratore, ed il prodotto del lavoro, cessavano la propria funzione storico-evolutiva; e i
“bisogni del lavoro” non erano più nemmeno
“merce” ma diventavano prodotti finanziari e come tali vendibili e messi sul mercato degli interessi privati.
Vedi, quando parlo di anima non mi riferisco a qualcosa di astratto né voglio prendere in considerazione la parte
“spirituale” che nel comune pensare attiene alla religione: no, mi riferisco a quell’
“anima umana” che è presente in tutti, che è generatrice del principio di vita che dà origine al pensiero, al sentimento, alla volontà, alla stessa coscienza morale o sociale, e nella quale risiedono
“i bisogni”, che si differenzia per cultura, ambiente, tradizione, stato sociale, famiglia ecc., ma che, se non trova cittadinanza nel
“quotidiano del lavoro” attraverso il riconoscimento valoriale della propria
“unicità e socialità”, come tutte le cose non utilizzate si atrofizza, si spegne.
Guardando l’esperienza di Solidarnosc avevo ritrovato quell’anima che non aveva scisso in se stessa i valori e le esigenze di giustizia da quelli della necessità del vivere e del mangiare e il tutto l’aveva fatto unificando i bisogni di un popolo senza sottostare più di tanto a
“regole di mercato” né a
“rivoluzioni ideologiche”. Ancora una cosa prima di parlare o, meglio, scrivere dell’oggi. Voglio essere chiaro. Credo profondamente
“nell’approccio imprenditoriale della vita” e quindi del lavoro in ogni accezione considerato, sia esso dipendente o meno, credo nella
“proprietà privata” della vita e del capitale, credo nel
“rispetto delle differenze”: ma tutto ciò non può essere ottenuto senza l’applicazione di regole sociali che unifichino
“in uno” i valori generatori di umanità, libertà e ricerca di verità che pre-esistono in ogni persona e ad ogni latitudine, ed occorre farlo con delle regole collettive che inducono alla partecipazione ed al
“diritto di cittadinanza sociale di quei valori” attraverso la corresponsabilità di esercizio. Di questo dovrebbe occuparsi la politica, sia essa partitica, sindacale, imprenditoriale, personale, familiare: ma ahimè…
Esiste e deve esistere libertà economica, finanziaria, culturale, ecc., ma esiste, o
dovrebbe esistere, uno Stato, nel senso ampio del termine, che attraverso la legislazione regoli tali libertà affinchè una di esse non raggiunga un livello di potenza tale da ridurre le altre in dipendenza e schiavitù.
Veniamo all’oggi. Per brevità mi soffermo solo su un aspetto tra quelli che attanagliano la nostra
“vita lavorativa” lasciando ad altre occasioni l’approfondimento su altri temi che pur meritano.
Ciò che le
tecnologie informatiche hanno reso possibile e fruibile in questo ultimo decennio mai si era affacciato sul pianeta Terra
(salvo pensare agli alieni, ma lì io non ci arrivo).
Provo, con il filo a piombo, a traguardare iniziando da un’angolazione. Oggi esistono nel mondo dei
supercalcolatori in grado di svolgere 22 milioni di miliardi di operazioni matematiche nel tempo di un secondo, e sono in mano a società private
(una di queste l’hanno piazzata in un paese vicino al mio), riesci a capire? Non è agevole, vero? Provo con un altro esempio. I cellulari di ultima generazione che sono nelle nostre mani e nelle mani di tantissimi ragazzi, cittadini del mondo, hanno una capacità di memoria tale che potrebbe contenere
“un milione di computer” simili a quello che la NASA utilizzò per inviare l’uomo sulla Luna. Sì, hai letto proprio bene,
“un milione”. Nelle nostre mani ed ancor più nelle mani private di pochi gruppi mondiali vi è un potenziale informativo tale per dimensione e velocità esecutiva, da rendere superfluo il pensare e l’apprendere. Tant’è che per i comuni mortali tutto
lo scibile umano che serve sta in un cellulare: l’orologio, la rubrica, gli appuntamenti, le fotografie, i giochi, come del resto la geografia, la storia, i libri, la cultura, ed anche le relazioni personali. Tutto lì, in palmo di mano e immediato. Per i mortali un po’ meno comuni, ma che in comune hanno l’interesse del profitto, a loro non sembra vero di poter disporre di una quantità assoluta di informazioni (
che noi stessi forniamo loro nel nostro agire quotidiano), e di utilizzarle a proprio beneficio.
“I grandi fondi finanziari e oscuri” sono i possessori sia di quelle informazioni sia di enormi quantità di denaro cartaceo (in passato la parità con l’oro non lo consentiva) facilmente trasferibile con un “clik” ed immediatamente esigibile, ed il tutto avviene in assoluta assenza di norme giuridiche che impediscano l’accumulo eccessivo, che pertanto diventa
“l’unico dogma”. Non ci sono più le sfide del mercato libero che in qualche misura regolava il bene, frutto del lavoro, ed il profitto, frutto dell’impresa.
Questa
abnorme quantità, concentrata in poche mani private, punta attraverso la speculazione finanziaria ad accumulare la valuta nei propri magazzini sottraendola di fatto al mercato, in modo da renderla dipendente. La distribuzione, o meglio la redistribuzione, di beni e servizi viene sottoposta alla loro finanziarizzazione, e come tale regolata.
Nella civiltà contadina che ha accompagnato per millenni l’evoluzione umana e sociale fino ad un centinaio di anni fa, un meccanismo simile veniva adottato da
coloro che “possedevano le sementi”. Non erano quelli che lavoravano la terra, né talvolta gli stessi proprietari terrieri, no, erano coloro che fornivano qualità e quantità di sementi non superiori alle necessità di sopravvivenza (o di mercato) e stabilivano quali terreni utilizzare o meno, e se un proprietario non garbava loro o non rendeva il dovuto, semplicemente quei terreni restavano incolti e le popolazioni rischiavano la fame.
Come vedi, nel metodo non è cambiato molto da allora, se non su un aspetto specifico. Le famiglie e le proprietà contadine, anche se analfabete, avevano consapevolezza di un tale metodo e, nella storia, con lotte e sacrifici l’hanno superato.
Oggi, il seme del mondo economico è la “carta moneta” ma fingiamo di non saperlo.
Ora provo con il filo a piombo a traguardare da un'altra angolazione. La Cina è la più grande potenza economica mondiale, ha superato gli Stati Uniti, è orgogliosa di se stessa e della propria millenaria cultura. Aprendosi parzialmente al mercato, è diventata il Paese dove i marchi del lusso si mettono in fila per poter entrare, detta la propria etica e visione valoriale, e chi sgarra si affretta a scusarsi. La Cina non gira più il mondo per elemosinare ma
“compra”. Da vastissime aree in territorio africano, ad aziende in territorio europeo ed americano; compra squadre di calcio, compra case e negozi, ecc.
Detiene
il maggior numero dei miliardari del mondo. Compra, paga in contanti e impone se stessa al mondo. Non a caso Trump è piuttosto incazzato. Chi l’avrebbe detto, ai tempi della rivoluzione maoista... Rimangono al proprio interno parecchi problemi ma, come sempre ha fatto, se non trova un accomodamento li risolve da sé. E’ di questi giorni, apparsa sulla stampa di casa nostra, la polemica pretestuosa su “Huawei” che con i propri prodotti informatici mina la sicurezza del mondo intero, a detta di Trump, come se le aziende americane, o altre, non fossero mai state violate.
Il continente africano, apparentemente negli anni si è liberato dalla schiavitù e dall’ imperialismo occidentale e quindi dovrebbe evolvere verso orizzonti di civiltà e libertà ben superiori a quelli attuali. In realtà tutti i settori decisivi dell’economia di quei paesi sono ancora saldamente nelle mani di imprese straniere che di volta in volta, anche attraverso la guerra tribale, finanziano i
“Ras di turno” come a loro conviene, utilizzando altresì forme di fondamentalismo religioso che negano una qualsiasi possibilità di cittadinanza a chi non appartiene a loro.
I gruppi estremisti, che cercano di risolvere tali controversie con le armi, trovano appoggi politici, militari ed economici, e coloro che cercano soluzioni meno cruente vengono emarginati ed il più delle volte uccisi.
La produzione di miseria serve come deterrente per tenere a bada coloro che la miseria e la povertà in casa propria l’hanno in qualche modo superata. Gli Stati Europei, tra i quali l’Italia, l’Olanda, la Francia, il Belgio, gli Stati Uniti, il Regno Unito, i paesi del Golfo arabo, la stessa Cina e la Russia, ancora oggi giocano sulla produzione di profughi e schiavi.
Non ci si è dati da fare per
promuovere negli anni un “ceto medio” con cultura adeguata e professionisti e quadri competenti, capaci di far funzionare uno Stato. Hai voglia poi di parlare di migranti, pensando che il problema sia risolvibile senza intervenire sulle cause che lo producono.
Analogamente, anche se con modalità differenti, avviene nei paesi dell’
America Latina. Anche lì, con un residuato imperialismo, non solo europeo, si sono assemblate culture cristiano-marxiste su un umanesimo che laddove prova ad evidenziare una certa autonoma gestione o visione sociale e politica, viene estromesso dal mercato mondiale, utilizzando le leve del debito inestinguibile, e talvolta della repressione. Recenti sono i casi dei migranti che incolonnati sulle strade del Salvador, dell’Ecuador, del Venezuela, del Messico e probabilmente di altri Stati
“cercano speranza” in quelle Nazioni che in realtà sono le stesse che mantengono critica la loro condizione di vita in casa propria, e che mantengono nelle proprie mani le condizioni e le risorse economiche utili al loro sviluppo.
Voglio ora “traguardare” ancora da un’ ulteriore angolazione. Stiamo assistendo ad un
collante finanziario-religioso-politico, che qua e là ogni tanto appare. Si assiste, nel mondo attuale, ad una disgregazione politica dell’umanità accampando appartenenze a fedi religiose differenti che in funzione a recrudescenze fondamentaliste, per ragioni di
“sicurezza nazionale” mirano a controllare in modo capillare e scientifico tutta la società affinchè diventi impossibile l’infiltrazione di un qualsiasi
“pensiero distorto” che abbia come effetto collaterale l’autonomia dei popoli e la reale indipendenza storica e culturale. Mi è agevole a tal proposito osservare come autoritarismi, seppur di diverso colore politico, trovino coagulo e si affermino nella guida delle nazioni, con l’intento di limitare il più possibile la libertà ed i valori generativi dell’umanità.
Tali movimenti diventano di facile lettura se si analizzano le prese di posizioni
critiche nei confronti di questo Papato. Critiche più o meno evidenti arrivano dal continente americano e da quello europeo strumentalizzando il dramma della pedofilia, sul quale, in realtà, questo pontefice è uno dei più acerrimi nemici. C’è in atto un
“collante protestante” che associa Trump (Stati Uniti), con Bolsonaro (Brasile), Mey (Regno Unito), ed alcune nazioni europee, che evidenzia politiche di nazionalismo.
La Chiesa russa, con Putin, stranamente fa sponda con la parte più intransigente di Israele nel gioco geo-politico mondiale, additando a questo papato la debole difesa dei valori cristiani, laddove i cristiani vengono da altri martirizzati brandendo ragioni religiose. Per non parlare dei paesi arabi o di quelli nei quali la dottrina mussulmana è legge di stato ed i cristiani, generalmente intesi, sono
“gli infedeli”. Non ultime sono le critiche mosse al Vaticano per il recente presunto accordo con il governo cinese nel riconoscimento dei vescovi nominati dal Papa ma in qualche misura graditi a Pechino. E tutto ciò trova appoggio all’interno della Chiesa Cattolica da parte di alcuni vescovi e laici che non trovano di meglio che accusare il Papa di apostasia.
Tutti questi interventi, se letti separatamente, sembrano incomprensibili: ma se si guarda la radice ci si accorge che la pianta trae origine da una comune visione del mondo e della tangibilità della persona umana, che deve essere piegata agli interessi di chi comanda, anche se declinati in forme e colori politici differenti. La vera difficoltà di questo papato è che il
Vangelo del perdono e degli ultimi, la contrarietà alla guerra, l’aperta sfida più volte lanciata sul traffico di armi e di uomini, la contrarietà alla pena di morte, la pervicace volontà di
“costruire ponti e non muri”, il
“Laudato si” sull’ambiente, il richiamo continuo alla povertà reale, che deriva già dalla scelta iniziale del nome Francesco, la messa all’indice del
“dio denaro”, tutto ciò rappresenta un pericolo per tutti coloro che vogliono gestire l’umanità, controllando perfino le coscienze in modo da poter agire, con maggior tranquillità, per fare i propri “porci comodi”.
Questo papato, richiamando la
“pratica quotidiana dei valori cristiani” e non solo la loro divulgazione accademica, è in aperto contrasto con chi non accetta il principio di inviolabilità e di intangibilità della vita e della libertà, sia essa individuale o collettiva.
L’ultima
“occhiata”, non ultima per importanza, riguarda casa nostra. Il nostro
“Bel Paese” che inserito in questo contesto europeo e mondiale si dibatte in se stesso senza grandi prospettive di riemergere con una visione di futuro meno fosca. I dati dei vari istituti di ricerca segnano le difficoltà oggettive: disoccupazione, povertà, precarietà, assenza di prospettive. Mi pare che la nostra
classe imprenditoriale, più che
“fare impresa” sia quasi completamente assorbita nel
“grande gioco finanziario”, restano attive le medie e piccole imprese che su scala mondiale rappresentano ciò che era l’orto di casa nella civiltà contadina.
Peraltro alcuni marchi industriali proseguono nel proprio posizionamento mondiale e pertanto a tali regole devono adattarsi. Restano ancora attive aziende che con la ricerca restano in dialogo permanente e fanno innovazione, ed
un tessuto sociale che non vuole rassegnarsi e che si esprime in varie forme di volontariato. E comunque non siamo un corpo separato dal resto del mondo e se nel mondo le regole applicate sono quelle che ho accennato, piaccia o non piaccia regolano anche noi.
Negli ultimi decenni non c’è stato uno sviluppo che ci contraddistingua, più che altro c’è stato un adattamento del
“sistema Italia” a sistemi da altri controllati e nei quali ci siamo inseriti. E questo lo vedo purtroppo, oltre che nelle aziende, anche nella cultura in generale, senza la quale, hai voglia crescere…
Dal punto di vista politico, pur senza nascondere le difficoltà che comporta la gestione pubblica, vedo che gli orizzonti di sviluppo della collettività si sono ripiegati in una prospettiva di autosufficienza che risponde più ad una logica di autoassoluzione che non al
“coraggio” che occorre per vivere e per scegliere come vivere.
Abbiamo
lider di maggioranza che “scimiottano” ed è già tanto se non rovinano ciò che è già precario, e lider di opposizione che cercano di
“sfangarla” per se stessi. E’ bastato che
“la finanza che conta” facesse
“uno starnuto di spred” che tutto il coraggio innovativo si trasformasse in
“piscio”. A tal proposito ridicolo e per certi versi pericoloso è l’atteggiamento che si vuole assumere in ambito internazionale spostando l’asse politico collaborativo verso Russia e Cina. Si potranno anche favorire aziende italiane e ricevere investimenti sul nostro territorio, ma entrambi questi blocchi, quando comprano, impongono la propria logica, chi con le armi, chi con la finanza, anche in campo religioso, giusto per non dimenticare.
D’altronde tutti sono stati eletti non più per le loro intrinseche capacità o visioni politiche ma attraverso un’abile analisi e gestione dei desideri popolari effettuata con adeguati algoritmi applicati ai dati informatici in loro possesso e che a ragion veduta sembrano portare risultato. Un po’ dovunque nel mondo siamo passati
dalla politica dei grandi ideali alla politica dei “selfi” e degli “spot” che per loro natura attraggono come le foglie di un albero ornamentale presso il quale, se ci rivolgiamo per trovare frutta buona che ci alimenta, restiamo a digiuno.
Avviandomi alla conclusione cerco di sintetizzare ciò che a mio modo di vedere è avvenuto e sta avvenendo e che ha incidenza sulla collettività e sulle persone che a tale collettività appartengono. Va da sè che il culto dello sviluppo attuato prevalentemente nelle cosiddette
“società avanzate” abbia portato tali società ad una
crescita del benessere complessivamente inteso, maggiori beni, maggiori servizi, maggiore tutela sociale, ecc … complessivamente a una vita migliore, e non credo nemmeno che lo sviluppo del capitalismo o, per contro, di culture marxiste, sia tutto da buttare nelle fogne.
C’era del buono in entrambe le visioni che, con conflitti molto aspri, hanno comunque raggiunto livelli di miglioramento delle condizioni di vita, e finchè tali conflitti sono riusciti a ridistribuire il risultato della loro affermazione in beni o solidarietà sociale, pur con grandi tragedie e guerre,
“si costruiva”. Perché, attraverso le dinamiche del conflitto tutti si era chiamati ad interrogarci ed a vivere in aderenza automatica ai grandi ideali che sostenevano tali azioni. Pur in termini sbagliati, si viveva in simbiosi con i valori, poi via via nel tempo il tutto è stato
“cartolarizzato” .
Specificatamente,
“carta” più o meno straccia si è fatto di tali valori,
“carta” più o meno straccia si è fatta del sapere,
“carta” più o meno straccia si è fatta dell’umanità,
“carta” più o meno straccia si è fatta delle aziende e dell’imprenditoria,
“carta” più o meno straccia si è fatto dell’oro.
Tutto è stato assoggettato a
“carta, più o meno straccia, anche “l’uomo”. E la
“carta” si è fatta
“bait” (esca) e bait sé fatto
“bit” che è l’unità di misura del contenuto d’informazione adottato con il sistema di numerazione binaria nei computer e nei cellulari (
quella che grossolanamente io chiamo la “matematica cinese”, quella composta da una sequenza di uno e zero, diversamente disposti) ed il
“bit” opportunamente accumulato e diagnosticato, ha prodotto il
“Bit-coin” che di per sé non ha sostanza, rappresenta il
“nulla” eppure in questo
“nulla” chi ci ha messo qualche soldo, nel volgere di un paio d’anni si è trovato miliardario.
Caro Giuseppe,
in questo bailamme descrittivo che uccide la speranza umana nell’aver capacità d’uscita, in realtà una piccola speranza mi deriva dalla Fede, e cioè dal ripercorrere a ritroso quell’antico e permanente soffio che è la vita presente in ognuno di noi. In ogni persona. Dovunque e comunque essa sia, perché se “Lui” non ci ha ingannati, il legame profondo che esiste tra libertà, verità, vita, e che risiede in ogni
“anima del pianeta” non puoi nè dominarla, nè ingannarla, nè ucciderla, vive già l’eternità e pulsa vita in continuazione.
Ecco, quando guardo razionalmente le cose cerco di usare
“il filo a piombo”, che segue un principio di gravità terrestre al quale tutti siamo assoggettati, se guardo le persone non posso fare a meno di
“traguardare l’anima” che segue un principio di amore, ed anche a quello siamo assoggettati. Ovviamente mettendo in campo tutti i limiti ed i peccati di cui dispongo.
Fai bene, fai bene il bene, e che Dio ci aiuti.
Un abbraccio, caro amico.
(
Enrico Forti) P.S. - Per darti sollievo ti allego il “Post” che ho pubblicato ieri sera sulla mia pagina “Facebook”. E’ in tema, ma sorrido al pensiero che tu, un “latinista della lingua italiana”, sia stato costretto a leggere “post” e “ace book”.…..Lo scritto, usalo a tuo piacere… Ciao! Talvolta
portando la mente
a spasso nei campi
alzi gli occhi al cielo
e…
ti accorgi che Dio esiste.
°°°°°